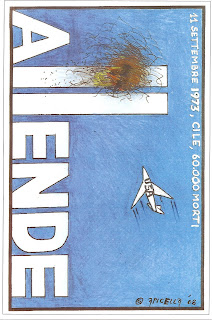Foto: Felipe Perez Roque, ex-ministro degli esteri cubano, Yemen, Ocalan, Talabani, “presidente” kurdo dell’Iraq, pacifisti
Ho vissuto nel mostro e ne conosco le viscere.
(José Martì, padre della patria di Cuba)
Non c’è bisogno di una maggioranza per prevalere, ma piuttosto di una minoranza arrabbiata, instancabile, impegnata ad appiccare roghi di libertà nella mente degli uomini.
(Samuel Adams)
Questo sarebbe in teoria un paese libero, ma i nostri tempi politicamente corretti e censori fanno sì che molti di noi tremano a esprimere vedute perfettamente giuste per timore di essere condannati. Così si compromette la libertà d’espressione, si evita di dibattere su grandi questioni, e grandi menzogne vengono accettate come grandi verità.
( Simon Heffer)
Certe forze, anche cattoliche, usano il dialogo come anestetico per addormentare il popolo… Quando non riescono a dominarci con la legge, arrivano con le preghiere e se non riescono a umiliarci e dominarci con le bandiere, arriva il fucile.
(Evo Morales)
Per ripulirmi della fangazza che continua a scivolarci addosso da quelli che “So’ comunista cosìììì, io!” e poi arricciano il naso su Chavez, o s’intruppano tra le squinzie e i fighetti iraniani ansiosi di berlusconismo (insomma si continua a parlare del tumore in fase terminale che è l’ottuso e arrogante eurocentrismo dei colonialisti “di sinistra”), ho potuto tuffarmi nelle gelide acque infuocate, purificatrici, di una terribile e grandissimo film di Brian de Palma sulla guerra all’Iraq. Fatto da un italoamericano, cioè USA e UE combinati, ma visto con gli occhi agonizzanti di un iracheno. Si chiama “Redacted” ed è un lavoro che inchioda gli Usa e le sue guerre alla colonna infame delle massime nefandezze della storia. Così come da noi non c’è un parlamentare come lo scozzese George Galloway che, con centinaia di camion e militanti, parte da Londra o da New York, sfonda a Rafah ed entra a Gaza, e prima ancora sfonda il necrotico pregiudizio integralista contro Hamas, non c’è neanche l’ombra di un cineasta, giornalista, videografo, turista politico, cooperante di Ong che sfiori il coraggio e l’onestà di questa agghiacciante denuncia. Ne parleremo nel prossimo post.
Oggi preme un altro tema. Ci sono compagni con cui ci si trova da anni uniti nel tenere per Cuba e per Fidel. Alcuni per ogni cosa cubana senza se e senza ma, vestali della rivoluzione, diffidenti verso l’hegeliana dialettica del pro e del contro, delle luci e delle ombre. Di fronte alla canea dei segugi vicini e lontani di Wall Street, del Pentagono, dei terroristi di Stato, tipo quel Pierluigi Batista che dal Corrierone espelle rifiuti di giornalismo su Chavez o Fidel (all’ombra del Berlusconi in fiore su ogni canale televisivo, strepita contro “il dittatore soppressore della libertà di stampa”), ci possono anche stare quelli del “senza se e senza ma”. Legittimo contrappeso. Ma forse non è del tutto costruttivo serrare gli occhi su certe vicende attuali d Cuba, di non peritarsi di vedere neanche una ruga piccola piccola sulla pur sempre bella faccia della rivoluzione. Si invecchia tutti, si sa, e le rughe si compensano con l’animo giovanile, non con il lifting. Magari non facendo più i cento metri in 10’’, ma la faticosa, lunga maratona. L’essenziale è che il cammino sia sempre in avanti, incamerando pure i due passi indietro. A dispetto delle pesanti rughe che segnano la gerontocrazia cubana, validissimi veterani della rivoluzione, ma che non sembrano disposti a cedere il passo alla seconda e terza generazione, pure da loro tirata su. Generazioni oggi decapitate con l’incomprensibile rimozione, malamente se non per nulla spiegata al popolo e agli amici, di due grandi protagonisti della resistenza cubana, Carlos Lage, vicepresidente, e Felipe Perez Roque, ministro degli esteri, amatissimo dal popolo, dai rivoluzionari latinoamericani, da Hugo Chavez, presunto successore di Fidel. Nebbiose argomentazioni gossipare hanno confuso più che illuminato la società cubana, mentre tutta l’intellighenzia rivoluzionaria latinoamericana ha capito benissimo che di duro scontro tra due linee si trattava. Da una parte Raul e i veterani, dall’altra i giovani discepoli di Fidel. Aperturisti gli uni, intransigenti gli altri? Chissà, ma vorrei che me, ce, lo si spiegasse. Senza bisogno di lettere di abiura di dubbia autenticità e di sbigottente memoria. E so quello che scrivo. Fidel, senza aggiungere altro, ha scagliato agli epurati l’anatema dell’”indegnità”. I suoi scritti quotidiani sono pillole di saggezza, strali di luce sulla vicenda planetaria nell’assalto finale del capitalismo agli uomini di buona volontà. Ma quella vicenda non è piaciuta ai migliori dei compagni, come non è andata giù la sommaria tirata di orecchi alle FARC colombiane perché combattono, dopo essere stati espulse con la mannaia dalla politica, e perché non rilasciano senza condizione i loro ostaggi (quasi solo politici e militari), quando nelle segrete del narcofascista Uribe agonizzano 500 loro compagni. Parlasse a Uribe, Fidel, no? Celia Hart, la più grande giornalista cubana, figlia di Haide Santamaria, l’eroina del Moncada, la pensava e l’ha scritta così, dopo una vita di amore e di lotta per Fidel e per la rivoluzione. I rivoluzionari stanno con i capi, ma, nelle more, stanno con il popolo e la sua rivoluzione. Cuba non necessita di chierichetti. La jinetera sul Malecon e il suo pappone non sono affatto rivoluzionari. Il perpetuarsi oltre i limiti biologici di una dirigenza, la recentemente accentuata differenziazione dei salari, sono probabilmente giustificabili. Ma nulla di più. Avete presente quell’ energumeno di “Bianco, Rosso e Verdone” ? Quello che urlava al figliolo, a accanito figlio dei fiori: “Io so’ comunista cosììì !” ? Gli altri no, non lo sono? Quelli che, proprio per l’indefettibile amore e sostegno per l’isola che c’è, si tengono caldi i punti interrogativi. Perché un conto sono gli uomini, un altro la rivoluzione.
Da Cuba, dalle spiagge sfolgoranti di venustà caraibiche en nature o quasi, spericolatamente, ci arrampichiamo sui ventosi duemila di altitudine dello Yemen, un paese in continua disputa tra rigogliosi verdi d’altura e le aride dune che incorniciano il Mar Rosso, macchiettato in nero da turbe di donne velate. Che in mare ci vanno vestite. E’ sbucato all’attualità, lo Yemen del Nord, da qualche anno riunito a quello del Sud, già marxista-leninista e poi epurato. Ora, lo Yemen, paese tra i più affascinanti del mondo, l’Arabia felix dei romani, conserva sul terreno e nell’animo quella che, insieme alla mesopotamica, è la più antica civiltà semita. Per quanto percossa da invasioni e domini feroci, ultimo quello britannico, che ne hanno determinato snaturamenti culturali e sociali e corruzioni politiche, io che ci ho vissuto la ricordo per l’ingegnosa originalità di un’architettura millenaria, tuttora ampiamente in piedi, ben conservata, per la turbolenta ricchezza di mercati, sempre di buon umore, che ti confondono di colori, odori, scambi umani, per la gentile disponibilità e generosa ospitalità dei suoi abitanti, non minimamente scalfita dall’incontro con costumi e modi drasticamente diversi, se non opposti. Ricordo l’allegra confidenza di mille e mille bambini, le cene-regalo che ci preparava la moglie del nostro affittuario, intelligente e capace sovrana della casa e della famiglia. Ricordo i lunghi pomeriggi sui bassi cuscini, folgorati dalle luci trasmesse dalle finestre di alabastro e vetro colorato, a discutere di storie antiche e attuali, di Harun el Rashid, il grande califfo, delle mene imperialistiche saudite alla frontiera Nord, dalla parte dei ribelli di Saada, di Israele e di democrazia così o cosà. L’unica sporcizia sulle strade era la sabbia che il vento spediva dal deserto, negli anni, poi. punteggiata da cartoni Nestlè e lattine di Coca Cola, la vera lordura. Prima di rifiuti non ce n’erano.
C’ero capitato dando i tacchi a Cossiga e ai suoi “falchi” assassini. Era il 12 maggio, mio compleanno e giorno di festa per il divorzio, celebrati uniti tra Piazza Navona, dove partirono le cariche, e Ponte Garibaldi, dove si moriva. Giornata di festa, dunque, anche per il più nero dei rigurgiti dalle classe politica italiana, lo schizoide ministro degli interni che, demente coerente, ritenne bene gestire la liquidazione di Stato di Aldo Moro con una conventicola di piduisti, definita “unità di crisi”. Inaugurò il suo personale curriculum di mandante scatenando una nuova squadra di sbirri travestiti da manifestanti, con licenza di uccidere. Ammazzarono Giorgiana Masi, 16 anni, inerme, sparando da Ponte Garibaldi. Ero proprio lì anch’io, che mi trascinavo con il ginocchio come un cocomero per il rimbalzo di un candelotto. Un medico compagno, il papà di Ilaria Alpi, mia futura collega al TG3 e mio successore nel pandemonio somalo, mi guardò la gamba e mi consigliò di zoppicare verso lidi lontani: avevano fotografato tutti quanti e gli ordini di cattura stavano partendo a mitraglia. Pure per me (poi se lo rimangiarono per mancanza di oggetto).
Dice, ma chi se ne frega non ce lo metti? Giusto, ma se racconto questa marginalità personale è perché fu essa a portarmi nello Yemen. E, visto il discorso iniziale, lo Yemen è un bel laboratorio di analisi per scoprire il precipitato eurocentrico. Ci rimasi due anni. Incontrai l’allora presidente Ibrahim El Hamdi, un figlio del nazionalismo socialista arabo, un poeta, un saggio governante, un lungimirante antimperialista, un capo che si sentiva germoglio della sua gente. Scrivendo per “Repubblica”, “L’Espresso” e “The Middle East”, avevo riferito qualche apprezzamento non proprio benevolo del presidente progressista all’indirizzo dell’Arabia Saudita che, da sempre affamata di Yemen, brigava contro l’unità con la repubblica marxista del Sud, fusione ambita da El Hamdi. L’opposizione filo-Usa, incarnata dal primo ministro Ali Abdullah Saleh, mi volle cacciare dal paese. Il presidente mi difese e assicurò la mia permanenza. Ricordo diverse sere nel suo modesto salotto, sui cuscini bassi, a parlare a tu per tu del suo argomento preferito, l’unità araba e la necessità di opporsi anche culturalmente ai tentativi di frazionamento della nazione, partendo dall’educazione dei giovani, priorità assoluta. Nessun governante yemenita aveva mai aperto tante scuole e università. Togliere il velo integrale alle donne? “Lo faremo a partire da loro, dalle donne, non d’autorità, succederebbe una rivolta e rovineremmo tutto il nostro lavoro. Ora importa che vadano a scuola e all’università, ne nascerà un movimento che potremo assecondare e sostenere”. Lo fecero fuori, con un colpo di Stato meditato in Arabia Saudita, specialisti anglosassoni-sionisti del regime change e misero al suo posto una specie di Al Maliki, sanguinario il triplo: il colonello Ahmed Al Ghashmi. E quella volta fui proprio espulso. Dopo, assassinato anche questa specie di mini-Sadat dopo che aveva fatto piazza pulita di ogni singulto progressista, americani e sauditi promossero a capo dello Stato il fedele primo ministro Ali Abdallah Saleh, che, col conforto dell’Occidente, riunì al ribasso i due Yemen e dura da allora, trent’anni. Oggi è l’uomo cui i suoi padrini hanno ordinato di sradicare a forza di massacri e di spopolamenti l’endemica rivolta degli sciti Houthi del Nord, motivata da secolari condizioni di abbandono e miseria, già sfruttata per le mire annessionistiche saudite e, ora, bollata di Al Qaida e di longa manus iraniana perché, scaricato lo sponsor saudita, si identifica con la causa antimperialista di Hamas e Hezbollah. E’ questo che sta dietro alle battaglie di queste settimane, in cui l’esercito di Saleh ha massacrato centinaia di civili e provocato centinaia di migliaia di profughi. Gente che, a tenore sociale, stanno come quelli di Gaza e in buona parte come tali si sentono. Naturalmente tra le quinte passano le inevitabili ombre israeliane. La frantumazione di qualsiasi unità statale araba e non araba nella regione è il punto uno del decalogo imperialista sionista.
Il primo provvedimento di Saleh fu di regalare alla sua clientela di trafficanti la decuplicazione della coltivazione del khat, in un paese che era stato l’ortolano e il caffettaro della Penisola arabica. Il khat e la foglia di un arbusto il cui lieve effetto stimolante aiuta, come la foglia della coca sulle Ande, a reggere le elevate altitudini e la fatica di un lavoro terrificante su terre e rocce renitenti. Le celebrate terrazze che scalinettano i precipizi yemeniti dai picchi gelati attorno a Sanaa all’altoforno del Mar Rosso, le più antiche del mondo, si erano ricoperte di arbusti di khat, in sostituzione dell’indimenticabile arabico. Il khat solleva e non nuoce se non con l’uso smodato, proprio degli espropriati ed esclusi sotto qualsiasi meridiano. Però, e qui sta il busillis, a chi ne controlla la distribuzione rende mille volte più del caffè, del cavolo, dell’uva, del legume, del cereale. E quei soldi sono il rastrello con il quale la classe opulenta e mercenaria da allora pettina il paese.
Lo Yemen ti rimane nel cuore. La bellezza durissima delle sue montagne che ritagliano un azzurro profondo e perenne, le sue valli percorse da wahdi che a volte vanno fatti ruscellare nelle grotte adibite a bagni turchi fin dai tempi delle “Mille e una notte”: cupi antri dai caldi vapori e dalle secchiate di acqua gelida lanciate da ragazzini sghignazzanti. Ne risorgi ai vestiboli del rilassamento, bianco-tunicato come un antico romano, uguale a tutti gli altri, tanto da entrare con naturalezza nel cerchio delle battute e degli scambi su come va il paese, il grano, il prezzo del khat, il mondo. Non so che fine abbiano fatto i tanti giovani, studenti, gli intellettuali, il mio padrone di casa falegname, le ragazze che, tolto in casa il velo integrale, volevano sapere se Sciascia aveva scritto qualcosa di nuovo, o se Adorno era ancora vivo. Rappresentavano lo sforzo di emancipazione del paese verso una modernità che, non nutrita dalla rivoluzione francese o dalla russa, doveva rifarsi a quell’illuminismo primario che gli arabi avevano sparso per il mondo nei primi secoli dell’Islam, prima che scaltri sovrani lo volgessero, proprio come la gerarchia nostrana, in religione di padroni e schiavi.
A volte i reduci da un viaggio di gruppo parlano dello Yemen a sopracciglia alzate e con gli angoli della bocca che precipitano sul mento. Di tutto quello che ho descritto poco sembrano aver visto e percepito. Ne hanno viste di cose, ma non gli sono piaciute. Degli edifici, incrollabili pur se di fango e paglia, alti miracolosamente otto-dieci piani, con fantasiosi ornamenti di calce bianchissima, traforati da finestre di alabastro e vetri scintillanti di colori; della sensibilità artistica manifesta in ogni forma di espressione comunicativa; della natura struggente, tra la maestà delle cime rocciose, i nugoli di capanne germogliate tra le dune e sotto le palme a bordeggiare il Mar Rosso, sui cui giacigli di corda rialzati ho trascorso notti stellate e chiacchierone, e la riservatezza di occulte valli verdi, del formicolio umano sorridente e disponibile, dei giovani ansiosi nelle spumeggianti e turbolente università; di tuto questo non v’è traccia. Restano le donne avvoltolate in tonache come animali, coperte impolverate nei tuguri in cui venivamo fatti alloggiare, i rivoli di acque nere che scendono dagli edifici, l’ arretratezza culturale, sociale, igienica, il fatto che alla mezza smettono di lavorare e si mettevano a socializzare masticando il khat, “mentre tu mangi perché io lavoro fino a sera”. C’è del vero anche in questo. Ma è quel pezzo di Yemen che si vede attraverso lenti occidentali, non necessariamente comuniste. Più preoccupante, retaggio ideologico, falsamente etico, di necessità, prima, poi metabolizzate in imperativi disumani, il discorso sul “lavoro che termina alla mezza e poi non fanno più niente se non masticare il khat”. E’ l’orgoliosa autoflagellazione di una società basata sulla produzione a qualsiasi prezzo, sulla necessità di lavorare, fare qualunque lavoro. Il progresso è lavoro, Il futuro è lavoro. La dignità è lavoro a più non posso. Quando il progresso dovrebbe essere la diminuzione del lavoro, l’eliminazione del lavoro inutile, lavoro per tutti in valida e utile quantità. Come nello Yemen, dove ci si ferma alle 14 e si incomincia a vivere. E a masticare il khat. Che non sarà il massimo. Vuoi mettere con i nostri aperitivi, prosecchini, cocktail, birroni, litrozzi, digestivi, grappini? Non mi pare che in Angola, dove le condizioni erano sicuramente peggiori, i combattenti cubani abbiano visto le cose così.
E’ la prova che anche tra chi si sente “comunista cosììì!” la tara dell’eurocentrismo, che in taluni nostri compaesani degenera in padanismo, non risparmia quasi nessuno in quella palude di autocompiacenza che rende imbelli e collaborazioniste le sinistre d’Occidente. Quelle che si fanno frantumare le corrose certezze ideologiche dai missili all’uranio dei paradigmi imperialisti, perenne strumento di dominio e genocidio, dai “selvaggi” agli “infedeli”, dagli “integralisti” ai “terroristi”. La saggia guida del relativismo, che Marx seguiva con puntiglio, sostituita dall'assoluto della civiltà superiore. A me, quando ho sottolineato il grottesco paradosso di chi, a sinistra, sosteneva la sedizione verde filo-Usa a Tehran, incapace di distinguere tra un governo complice degli USraeliani nell’uccisione dell’Iraq da un governo che, su altro piano, come Hamas e Hezbollah si oppone alla calata dello stivale imperialista sulla sua casa, una sprovveduta ma altezzosa confusionaria diceva: “Grimaldi s’è messo il turbante" . Non tengo turbanti, ma neanche lenti deformanti fabbricate a Wall Street. Tuttavia, capita che turbanti possano, a proprio dispetto, tingersi di rosso.
Ma sull’oceano della spocchia autoreferenziale naviga la più sconfinata delle armadas. Si annida nelle ONG della solidarietà fondata sul fondamentalismo della non violenza, del “dialogo”con chi ti spara in fronte, del pararsi il culo a destra e sinistra e vivere in compatibilità grilloparlantesca con l’esistente, deprecato, ma coperto a sinistra. Sta negli assennati equilibristi che, lacrimano sulle vittime di Gaza o Kandahar, ma dagli orgasmi che furoreggiano (specie le giornaliste donna) per il serial killer dei padroni Obama o, ora, per Ted Kennedy, chiudendo gli occhi sui crimini sociali e militari del primo e sulla totale adesione dell’ultimo germoglio di una dinastia mafiosa e puttaniera allo stragismo razzista di Israele. Uno, quest’ultimo, che grazie all’élite è stato tirato fuori per i capelli dalla connivenza con la morte della povera Jo Kopechne, finita con lui nel lago al termine di una gita alla papi e lì abbandonata e occultata per due giorni. Uno che cantava da solista nel coro neocon del “Saddam alleato di Al Qaida e pronto a polverizzare New York con le sue armi di distruzione di massa”. Ha poi votato contro la guerra? Troppo tardi, alla guerra aveva già steso il tappeto rosso. Sono quelli che viaggiano nel vano bagagli degli F16, o si fanno trainare dai tank Merkava, per gettare fiorellini su macerie ed ecatombi, accompagnandoli col ditino che ammonisce “non fate i violenti, gli integralisti, gli Al Qaida, i terroristi, gli estremisti! Venite a dialogare”.
C’è una parte del popolo palestinese che, visto lo sbriciolarsi del cemento laico nella corruzione, nel tradimento o nell’impotenza, ha trovato un nuovo collante nazionale e antimperialista nella religione, che ha potuto compensare la dissoluzione della solidarietà internazionalista e delle forze politiche “democratiche” con l’innesto nella vasta comunità islamica, polo, con l’America Latina, della resistenza al primo dei nemici dei popoli, delle classi e della vita. Potremmo permetterci rimpianti, ma non astensioni e, peggio, condividere le strumentalizzazioni del potere bianco cristiano che per continuare a fagocitare il mondo ha bisogno di diabolizzarne una metà. Si susseguono i convegni e le gite politiche delle turbe del giusto, del buono, della pace, dalle parole d’ordine “dialogo”, “incontro”, “parliamoci”, “conosciamoci”. Strateghi della pace che, se spuntano le armi di chi si difende dall’estinzione forzata, non fanno un baffo a quelle degli estintori. Morgantini, Tavola della Pace, Un Ponte per, Cantieri di Pace, Attac, preti costruttori di pace e amici di Abele, Sbilanciamoci (quelli che limano le unghie al capitalismo con Tobin Tax e bilanci partecipativi), non violenti di ogni risma e gregge propongono il dialogo a chi schiatta sotto stupri e sterminii, alla formica con l’elefante. Non concepiscono che la formica rossa prima debba iniettare il suo veleno nella zampa del pachiderma, per poi farlo inginocchiare e “dialogarci” da vicino. Antistorici e antiscientifici, sollecitano la vittima alle buone maniere, pregano il carnefice di non infierire. Non si sporcano le mani con chi da sempre è costretto, per infliggere quel danno all’oppressore che, solo, può cambiare i rapporti di forza, a rispondere con tutti i mezzi a disposizione. Hamas, Hezbollah, quelle resistenze nazionali che chiamano sommariamente Taliban, o deformano nell’ Al Qaida made in Usa, non esistono nel selezionato panorama della loro solidarietà. Compiaciuti e fieri, alzano la ruota come galli cedroni quando allestiscono un concertino, o un film in cui palestinesi e israeliani suonano insieme o mettono su un centro culturale comune, così “aprendo la strada alla conoscenza e alla riconciliazione tra i due popoli”. Poi però restano abbarbicati al vessillo piratesco dei “Due Stati per due popoli”, conferma di uno Stato fuorilegge, potente, espansionista ontologico, monoconfessionale e razzista (che oggi sollecita i suoi correligionari dentro e fuori a non sposarsi con i non ebrei), con al guinzaglio uno pseudostatarello senza diritti, confini, sovranità, alleati. Senza 5 milioni di cittadini espropriati e cacciati nei decenni. E il dialogo lo vogliono in Iraq con i briganti che, pagati dall’invasore, hanno scavato le fosse per il proprio popolo. Un Ponte per, esaurita la saga delle due Simone rapite e liberate nella sceneggiatura Sismi-Scelli, s’inventa un “crescente movimento di cittadini che cercano di porre fine alla violenza, alla corruzione e all’occupazione attraverso i mezzi non violenti”. Sabotaggio della Resistenza. Roba da infami. Tutti uguali, tutti alla pari che devono rinunciare a qualcosa: alla vita gli uni, agli eccessi gli altri. Rieccola la società (ci)vile, cara ai ciurlatori nel manico e agli opportunisti annidati nelle nicchie del colonialismo “dalla faccia umana”. E’ democratica, è laica, è perbene, è nonviolenta. E’ ammessa nella sala d’aspetto di occupanti e fantocci. Magari, si augura Un Ponte per in sintonia con il regime burattino e con gli occupanti, prevalesse su quella Resistenza irachena, indomata da sei anni, che, rintanatisi gli statunitensi nei loro covi fortificati per non dover esibire altre bare alla CNN, ora sta facendo vedere i sorci verdi da Mosul a Ramadi, da Baghdad a Basra, alle armate di ascari indigeni e ai peshmerga curdi al comando dei due narcotrafficanti Talabani e Barzani e al soldo di Israele. Non solo, mentre scrivo giunge notizia di quattro marines fatti fuori tra Mosul e Baghdad e di altrettanti liquidati in Afghanistan. Gli sta dicendo davvero male, alla faccia dei dialogisti.
In Palestina da decenni mettono insieme, in cortei alternativi alla resistenza, gruppetti di indulgenti israeliani, magari sionisti come Uri Avneri, e qualche rassegnato palestinese, spesso membro di una borghesia stufa di rimetterci resistendo. In tutto questo tempo la Palestina è stata ridotta in un minuscolo arcipelago di isolotti, nessuna famiglia palestinese ha evitato un tributo di sangue, di carcere, di tortura, di umiliazioni. Preceduti dalla credibilissima accusa del numero due di Fatah, l’incorrotto Faruk Khadumi, di aver complottato con israeliani e Usa per avvelenare Arafat, i caporioni di Fatah hanno recentemente tenuto a Betlemme il loro congresso. Non l’hanno voluto all’estero, come la diaspora correttamente esigeva, perché la selezione dei delegati non avrebbe potuto essere governata dall’occupante israeliano e dai pretoriani palestinesi addestrati e armati dal generale Usa Dayton. Un congresso-farsa dei ladroni e rinnegati, della vuota retorica rivendicativa, della conferma manipolata del quisling Abu Mazen e della sua cricca di venduti, a partire dai due ex-capi della Gestapo dell’ANP, compreso l’abbietto Mohammed Dahlan, satrapo e golpista a Gaza, doppio agente Cia e Mossad, al centro del complotto contro Arafat. Certo, hanno anche eletto al Comitato Centrale il leader dell’Intifada, l’odiatissimo Marwan Barghuti, portavoce di una base repressa, ma forse non doma. Ma quello non preoccupa: ci penseranno i boss israeliani a neutralizzarlo con i suoi tre ergastoli. Hanno rimasticato la fandonia dei due Stati, basta che vi sia uno spazio dove possano chiamarsi “presidente” e raccattare le briciole avanzate dal pasto cannibale israeliano. Hanno giurato che non riprenderanno i colloqui di pace, di resa, finchè continuano gli insediamenti. Non finchè non vengano ritirati tutti gli illegali insediamenti (Ginevra proibisce lo spostamento di popolazioni in territori occupati), solo finchè non siano congelati. Roba da tsunami di pernacchie USraeliane. Infatti, sicuro dell’impunità mondiale e ANP, Netaniahu ha subito annunciato la costruzione di altre 500 case, più dependance, scuole, piscine, palestre, campi sportivi e ha avviato la definitiva “bonifica” di Gerusalemme Est.
Ora è in preparazione una spedizione in Palestina delle sigle pacifiste di cui sopra. Quale il partner in loco? L’ANP, Fatah, rilegittimati dal consenso, oltreché della “comunità internazionale” incondizionatamente filosionista, da questa industria del dialogo, della considerazione di “entrambe le parti in conflitto”, della “costruzione di ponti”, del “superamento delle barriere”. Implicito è l’immorale e tossico messaggio della equipollenza delle posizioni, dei torti e delle ragioni, che nessuno è del tutto nel giusto e nessuno completamente nell’ingiusto, che entrambe le parti vantano rivendicazioni legittime e dunque devono ascoltarsi per comprendersi e riconciliarsi. Fuori gli estremisti. Simmetrie infami. Equivalenze tra assassino e assassinato. Come quella tra la denuncia delle porcate etico-politiche del guitto mannaro e il tiro a segno di Feltri sul direttore di “Avvenire”, Boffo, su Santoro, o sulle giornaliste dell’Unità. Sono quelli che a casa nostra invitano tutti “a moderare i toni”, senza distinguere tra chi spurga merda e chi scopre la cloaca. Napolitano è il portabandiera di costoro. Ed è evidente che ne trae beneficio la cloaca. Nella storia non c’è un caso, neanche quello dell’India, dove Londra mise il pacifista Ghandi a capo del paese sottrattogli da anni di lotta armata comunista e nazionalista, in cui un regime coloniale abbia ceduto il potere senza una lotta e resistenza di popolo, collegati a pressione internazionale diretta. Pensate al Sudafrica: anni di lotta violenta affiancata da boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni internazionali. Quella campagna BDS che ora i veri amici della Palestina hanno raccolto dal cuore sano di quel popolo e diffuso nel mondo e che è vista con fastidio, se non con orrore, dagli scherani pacifisti del colonialismo. Immaginatevi cosa avrebbe raccolto qualcuno, allora, se avesse suggerito agli africani morti di fame dei bantustan di cercare di capire il punto di vista dei signori bianchi. Facciamola finita con tali ipocriti lavacri di coscienze criptocolonialiste.
Negli ultimi tempi sono ripartite alla grande le campagne islamofobiche. L’11 settembre è lontano e anche ampiamente sputtanato nella versione ufficiale (se ne è accorto con un trafiletto anche “il manifesto” che fino a ieri dava del paranoico a chi vedeva l’abbagliante evidenza del falso). Toccava rilanciare. I punti di forza sono ora la Libia e l’Iran. Avranno questi regimi tutti i difetti del mondo, ma l’ampiezza del coro e il livello tonitruante della musica rendono sospetti. Come ai tempi del Darfur, rivelatosi nei suoi termini etnici, religiosi e politici una bieca invenzione propagandistica per mobilitare la “comunità internazionale” all’assalto del Sudan. Sull’appassionata adesione alla rivolta della borghesia filoamericana in Iran ne ho già dette anche troppe. Ora quella truffa è stata accantonata e rimangono in pista solo gli isterismi bellici di Israele. Nei guai in Afghanistan, gli Usa hanno troppo bisogno del concorso persiano, insieme a quello indiano, per stringere nella morsa il cuore pashtun di questa regione asiatica, diviso tra Afghanistan e Pakistan e insofferente da sempre a ogni dominio straniero. La Libia ha il pregio di essere pure dannatamente araba, oltreché musulmana e, visto che l’incontrollabile Gheddafi sta sempre lì, a dispetto di guerre per procura, bombardamenti, sanzioni, satanizzazioni, perché non bastonarlo, non senza qualche motivo, con la storia dei migranti. Tanto più che, da presidente dell’Unione Africana, la Libia non è proprio il partner ideale per occultare o giustificare i crimini neocoloniali UE-USA nell’Africa da riconquistare, dalla Somalia al Congo, dall’Eritrea al Sudan, dalla costa occidentale a quella orientale.
Peccato che i giovanotti catanesi dell’ONG “Fortress Europe”, ampiamente citati nei suoi accanimenti antilibici da Corrado Jacona in “Presa diretta”, abbiano per fonte e compagna di merende gente come Human Rights Watch, l’ONG statunitense scandalosamente squilibrata a favore di Israele, governata dal bandito della destabilizzazione di paesi non clienti e della speculazione finanziaria George Soros, ebreo ungherese intimo di Israele. Peccato anche che gli eritrei che stanno a cuore a questa ONG e che fuggono da una “sanguinaria dittatura” (sostenitrice, per l’appunto, delle forze di resistenza somale), perlopiù si indirizzano a frotte, fiduciosi e propagandisticamente meritevoli, verso la terra promessa israeliana. Stupisce, ma neanche tanto, il silenzio di “Fortress Europe”, sui profughi da Etiopia, Nigeria, Palestina occupata, Iraq. Sono forse imbarazzanti perchè coinvolgono governi amici?
Teorici della sineddoche su vasta scala, in questo contesto di solidarismi a tutto tondo, sono anche quelli di Azadì, altro virgulto solidarista catanese che si occupa del “dramma dei Kurdi”, con la k, come vuole Azadì. Il particolare, che per questi attivisti diventa automaticamente il generale, sono i kurdi del PKK in Turchia, quelli di Ocalan per intendersi. Dal particolare turco, Azadì trae valutazioni ed estende condivisione e solidarietà a tutte le realtà curde nella regione, in Iraq, Iran, Siria e Turchia, vuoi di minoranza oppressa, vuoi di regime opprimente. Mi fanno riandare a quel Musacchio, seguace di Bertinotti e oggi di Vendola, che, tra le tante fesserie pronunciate nel corso di un’immeritata carriera politica, una volta mi rampognò per avere io dato al kurdo iracheno del kurdo iracheno, cioè del gaglioffo al servizio delle strategie USraeliane nella regione. “La causa kurda è sacra per tutti noi” proclamò l’incompetente a petto infuori, anche lui pratico della sineddoche per cui al combattente per la libertà kurda in Turchia (molto più simpatico di quello palestinese o iracheno), deve corrispondere per forza il corrotto feudatario kurdo in Iraq,
Mentre il capo del PKK, subito dopo la sua cattura, ha disposto la fine della lotta armata, i suoi seguaci hanno alternato tregue a riprese vivaci. E nessuno ne dovrebbe mettere in dubbio la legittimità a fronte della condizione di feroce repressione cui è sottoposta la popolazione kurda di quel paese. E’ che non tutti i kurdi sono PKK e, forse, nel PKK, non tutti i petali del fiore sono incorrotti. Per Azadì è stata la Guerra del Golfo ad aver avuto il merito di portare alla ribalta “il dramma kurdo”. Peccato che quella guerra colonialista contro l’avamposto iracheno della resistenza laica e progressista araba, aveva in certi kurdi iracheni la sua quinta colonna. A dispetto del fatto che Saddam avesse concesso al Kurdistan iracheno l’autonomia, l’autogoverno, la parità della lingua kurda con quella araba, università e sviluppo, cosa senza uguali negli altri paesi, due capitribù iracheni, contrabbandieri e narcotrafficanti, era dagli anni ’70 che stavano nel libro paga della Cia e mandavano i loro peshmerga allo sbaraglio contro le truppe nazionali. Peccato che lo sterminio dei kurdi iracheni e la loro strage per gas iracheno negli anni’80 siano una sporca invenzione, ampiamente smentita da fonti addirittura Usa (New York Times, 31/1/2004), non citate da Azadi che ripete l’antica giaculatoria USraeliana degli 8mila gassati da Saddam. Peccato che le fosse comuni citate da Azadi, sia siano scoperte solo piene di sunniti iracheni, in un modo o nell’altro collegati alla resistenza contro l’occupante. Peccato soprattutto che Azadi comprometta la sua identità di sostenitore dell’autodeterminazione del popolo kurdo, trascurando gli spuri legami che sono andati stabilendosi nei decenni tra kurdi iracheni o iraniani e Israele. E trascurando anche i rapporti altrettanto spuri tra i despoti kurdi in Iraq, contrastati dalla parte migliore, ma mai citata, del loro popolo, e il PKK e il Pejak in Iran (Partito kurdo della vita). Tutti scoperti, da giornalisti investigativi come Seymour Hersh, traboccanti di armi statunitensi. Il dubbio è solo se gli siano stati forniti direttamente dagli Usa, da Israele, o siano stati passati dal regime fantoccio di Baghdad, al cui esercito erano destinate, ai peshmerga. Peshmerga addestrati da Israele sotto l’occhio compiaciuto di delinquenti come Talabani, “presidente” quisling dell’Iraq, o come Mahmud Barzani, tirannello del Kurdistan iracheno, che entrambi hanno accettato enormi investimenti israeliani, ceduto ampie zone edificate o coltivate a proprietari israeliani e illegittime concessioni petrolifere a compagnie occidentali. Altro che Kurdistan unito e libero. Azadì però non ne parla. L’autodeterminazione di un popolo svapora quando si ha per compare un Israele che fa la guardia al tuo trono e ai tuoi profitti. E’ nota la strategia USraeliana di frazionare lungo linee etnico-confessionali il mondo arabo e l’intero Medioriente. L’Iraq dei fantocci e la Turchia saranno pure alleati, l’Iran è il nemico mortale, in ogni caso meglio aver a che fare con piccoli stati rabbiosamente etnici, che non con grandi unità multinazionali dal peso regionale che può far ombra all’espansionismo israeliano. In questo contesto, il ruolo disintegratore di una società clanica, feudale, socialmente e culturalmente arretrata come quella kurda di Iran e Iraq è oggettivamente e, nel caso dei dirigenti, consapevolmente di apripista dell’imperialismo. Il PKK e Azadì farebbero bene a tenersene lontani. Anche dalle confraternite Cia-Mossad che hanno scatenato la fallita rivoluzione verde nell’Iran degli ayatollah. Ayatollah assassini dell’Iraq, ma questo non conta nulla per nessuno. L’ultimo proclama degli integerrimi di Azadì? “Impediamo l’intervento di Ahmadinejad alla conferenza delle Nazioni Unite, chiediamo che venga arrestato per l’uccisione di centinaia di manifestanti (bum!) dopo le elezioni….”. Netaniahu, però, sì che va bene alla conferenza e anche Talabani e anche Uribe e anche i golpisti dell’Honduras e perfino Berlusconi e Obama e i tagliagole kosovari e i fantocci stragisti afghani o pachistani…
Bongiorno o…buonanotte?
E’ morto Mike Bongiorno. Mai ovazione fu così unanime e tonante, da destra a sinistra. Un grande uomo, un maestro, un leone. Così ogni intellettuale, ogni uomo della strada, ogni gazzetta e ogni canale. Ne fremevano le fronde sulle alture dall’impareggiabile sportivo domate. S’è tolto dai piedi il giullare del peggio del peggio, il più possente diffusore della putrescenza pubblicitaria, un cretino furbo e inconsapevole. S’è zittito un inno al rincoglionimento.